| |
|
 |
Johann George Sulzer
Teoria generale delle Belle Arti
Introduzione, traduzione e note di
Alessandro Nannini
Presentazione di
Fernando Bollino
(2011, pp. XCII-225, € 28.00)
 
|
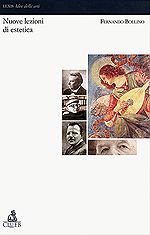 |
Fernando Bollino
Nuove lezioni di estetica
(2011, pp. 158, € 14.00
 
|
 |
Fernando Bollino
L'arte in opera
Itinerari di Gérard Genette
Con scritti di
Gérard Genette, Riccardo Campi, Alessandra Corbelli
(2006, pp. 180, € 16.00)
 
|
 |
Alessandra Corbelli
L'estetica musicale di Jean-Jacques Rousseau
Con un saggio di
Fernando Bollino
(2006, pp. 180, € 16.00)
 
|
 |
Jaques Rancière
Mallarmé o la politica della sirena
Traduzione di Alessandro Serra
Con la collaborazione di Martin Rueff
(2000, pp. 97, £ 18.000)
Mallarmé non è né l'esteta
a caccia di essenze rare e di parole inaudite né il pensatore silenzioso o
notturno della poesia troppo pura per essere mai scritta. Se la sua
scrittura è difficile, lo si deve al fatto che obbedisce a una poetica
rigorosa, corrispondente a una coscienza acuta della complessità di un
momento storico e del ruolo che in esso deve assumere la poesia. Difficoltà
leggera come i giochi di una piccola sirena che sa ingannare la fame di un'orco.
J.R.
Jaques Rancière
insegna filosofia all'università di Paris-VIII (Vincennes/Saint-Denis).
Autore di numerose opere sulla storia e il pensiero politico del secolo XIX,
ha pubblicato tra l'altro La Nuit des prolétaires, 1881; Le
Maître ignorant, 1887, La mésentente, 1995, La parole muette,
1998. |
 |
Gérard Genette
L'Opera dell'arte.
I. Immanenza e Trascendenza
(1999, pp. 294, L. 40.000)
In che cosa "consiste"
propriamente un'opera d'arte? E in quali modi essa può
"trascendere" i limiti del suo stesso consistere oggettuale. E
come eventualmente varia tale "consistere" e il suo
"manifestarsi" a seconda che si tratti della Gioconda
(oggetto "materiale" unico), del Pensatore di Rodin
(scultura bronzea prodotta in più esemplari teoricamente "identici e
intercambiabili"), di una performance jazzistica alla Charlie Parker
(atto irripetibile), della Certosa di Parma di Stendhal (oggetto
"ideale"), della Scultura invisibile di Oldenburg
(operazione "concettuale"), e così di seguito?
Attraverso una straordinaria serie di
analisi ed esemplificazioni condotte con lucidità teoretica e rigore
tassonomico, Genette prospetta una duplicità di fondo che caratterizza i
"modi di esistenza" delle opere d'arte, ovvero la loro Immanenza
(ciò in cui consistono, appunto) e la loro Trascendenza
(ciò che in qualunque forma travalica tale consistere per aprirsi,
infine, alla funzione "operale" delle opere stesse, ossia al
loro agire).
A sua volta l "modo d'immanenza"
si presenta articolato in due "regimi" alternativi, il regime autografico
(tipico di un oggetto materiale come la Gioconda) o il
regime allografico (tipico di un oggetto ideale come la Certosa)
- la terminologia qui è mediata da Nelson Goodman con il quale Genette
instaura un confronto serratissimo. Il "modo di trascendenza",
invece, introduce già ai contenuti trattati nel secondo dei due volumi
(sottotitolato, appunto, La relazione estetica, Clueb 1998) di cui
si costituisce la presente Opera dell'arte genettiana.
* * *
Formatosi alla scuola di Roland Barthes,
docente all'École Normale Supérieure, Gérard Genette (Parigi
1930) è uno dei più brillanti critici e pensatori europei contemporanei.
Ha conseguito grande notorietà con la serie Figure pubblicata in
Italia da Einaudi (I. Retorica e strutturalismo, 1969; II. La
parola letteraria, 1972; III. Discorso del racconto, 1976),
alla quale occorre aggiungere ora un recentissimo Figures IV (Seuil
1999): con questa serie Genette ha contribuito a innovare fortemente
criteri, metodi e analisi della critica e della teoria letteraria. Sempre
presso Einaudi sono usciti Nuovo discorso del racconto (1987), Soglie.
I dintorni del testo (1989), Palinsesti. La letteratura al secondo
grado (1997), mentre da Pratiche Editrice sono stati pubblicati Introduzione
all'architesto (1981) e Finzione e dizione (1994). Ricordiamo
inoltre Mimologiques. Voyage en Cratylie (1976) e le raccolte a sua
cura Théorie des genres (1986) e Esthétique et poétique
(1992), tutte edite da Seuil. |
 |
Gérard Genette
L'Opera dell'arte.
II. La relazione estetica
(1998, pp. 273, L. 34.000)
Come muta il nostro modo di rapportarci
volta a volta con un ciottolo di fiume, un paesaggio, un arte-fatto
(mettiamo: uno scolabottiglie), un'opera come la Venere di Milo?
Può la riflessione teorica sull'arte garantire nella relazione estetica
la distinzione fra due piani, uno genericamente "estetico" e l'altro
specificamente "artistico"? E può farlo, alla fine,
abbandonando legittimamente la domanda essenzialistica del "che
cosa è?" (l'arte) per dislocarsi sul terreno funzionale del
"quando?" (o magari del "come?").
Contro ogni oggettivismo volto a ricercare nell'opera
in quanto tale i fattori della sua bellezza e artisticità, Gérard
Genette adotta una prospettiva teorica rigorosamente soggettivistica:
"non è l'oggetto che rende estetica la relazione, ma la relazione
che rende estetico l'oggetto". Ci sono diversi modi di fruire di un
"oggetto estetico" a seconda che il suo valore aspettuale
produca semplicemente un'attenzione e un apprezzamento
soggettivi e mutevoli ("mi piace, è bello")
ovvero che si riconosca in esso (a torto o a ragione) anche una candidatura
(intenzionale) a essere apprezzato come opera fra le opere (d'arte).
In specifico, la ricezione di un'opera d'arte non potrà che essere
modulata anche da una complessa trama di variabili di tipo storico e
culturale.
Il titolo principale, L'Opera dell'arte,
sta dunque a designare, ambiziosamente, l'operare dell'opera d'arte
stessa, un operare (è questa la funzione artistica) che agli occhi
del fruitore "sembrerà" oggettivamente motivato, ma che dal
punto di vista della teoria estetica, risulterà tanto più libero,
rischioso, piacevole, quanto più sarà restituito alla sua autentica
dimensione soggettivistica. |
|

|
Luciano Anceschi
Che cosa è la poesia?
Nuova edizione riveduta a cura di F. Bollino
(1998, pp. 190 - L. 25.000) |
|

|
Leonardo Cozzoli
Il linguaggio senza nome.
Estetica, analogia e belle arti in Kant
(1996, pp. 1996 - L. 25.000) |
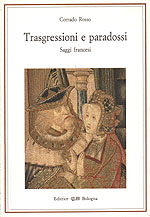 |
Corrado Rosso
Trasgressioni e paradossi.
Saggi francesi
(1994, pp. 180 - L. 25.000) |
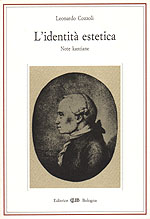 |
Leonardo Cozzoli
L'identità estetica.
Note kantiane
(1993, pp.131 - L. 18.000) |
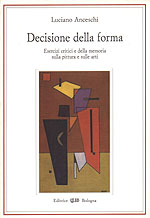 |
Luciano Anceschi
Decisione della forma.
Esercizi critici e della memoria sulla pittura e
sulle arti
Introduzione di Renato Barilli
(1993, pp. 299 ill. - L. 40.000)
|
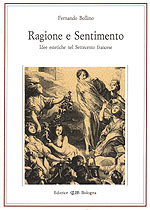 |
Fernando Bollino
Ragione e sentimento.
Idee estetiche nel Settecento francese
(1991, pp. 305 - esaurito) |
| |

|