|
14/1996 Ida
Zaffagnini
Questa
contrapposizione fra scienza e retorica sembra basarsi sulla
fondamentale distinzione che Hobbes pone all'interno dell'ingegno
naturale dell'uomo fra giudizio e immaginazione o fantasia.[vi]
In Elementi di legge,
dopo avere osservato che la differenza degli ingegni fra gli
uomini "trae la sua origine dalle differenti passioni e dai
fini ai quali il loro appetito li guida" e che, pertanto,
chi è incline ai piaceri sensuali è meno allettato dalle
immagini di gloria e di onore che stimolano quella rapidità
di pensieri e quella ferma direzione verso un fine in cui
consiste un buon ingegno, Hobbes rileva che, nel confrontare
le cose che si presentano alla mente, "un uomo si diletta o
col trovare una inaspettata somiglianza in cose per altri
versi molto dissimili, ed in questo gli uomini pongono l'eccellenza
della fantasia; e da ciò derivano quelle piacevoli
similitudini, metafore ed altri tropi, mediante i quali sia i
poeti che gli oratori hanno in loro potere di fare piacere o
dispiacere le cose, e di farle apparire in buona o cattiva
luce, come a loro piace; o anche nel discernere
improvvisamente una dissomiglianza in cose che per altri versi
appaiono identiche". E questa virtù della mente, grazie
alla quale gli uomini giungono alla rigorosa e perfetta
conoscenza, è comunemente chiamata con il nome di giudizio:
infatti giudicare non è altro che distinguere o discernere, e sia la
fantasia che il giudizio sono comunemente compresi sotto il
nome di ingegno.[vii] Dunque
l'ingegno è comune alla scienza e alla retorica ma la
scienza, che mira alla conoscenza certa, richiede soprattutto
il giudizio, mentre la retorica, qui unita alla poesia, fa
leva sulla fantasia e mira a persuadere lusingando gli affetti
con il gioco equivoco delle parole. Sembrano
così delinearsi due ambiti distinti nell'operatività
ingegnosa dell'uomo, scienza da un lato, poesia e retorica
dall'altro, guidati da facoltà diverse e con modalità e
finalità diverse. Ma,
ed è questo il problema che ci poniamo, veramente la poesia
si identifica completamente con il sapere retorico e si
risolve in un gioco illusionistico che, facendo apparire le
cose "in buona o cattiva luce", ha per fine la
persuasione? o invece poesia e retorica, per quanto nei testi
hobbesiani si possa sottolineare più di un debito pagato ad
una situazione storica e culturale che della loro contiguità
era profondamente intrisa, non vengono sottilmente
distinguendosi fra loro, nella contrapposizione comune al
sapere scientifico, delineando campi diversi per modalità
operative e per fini? In sostanza, si tratta di verificare se,
pur con ambiguità ed incertezze, sia possibile individuare in
Hobbes l'emergere di una prospettiva di grande rilievo
storico e teorico in cui la bellezza e le arti si ritagliano
un ambito proprio, con prerogative specifiche, diverse e
distinte non solo dalle modalità e finalità conoscitive
della scienza ma anche dalle modalità e finalità persuasive
della retorica. Naturalmente
non mancano soprattutto nelle pagine di critica letteraria,[viii]
pur nella vivacità e freschezza con cui Hobbes anima, a volte
con spunti geniali, i concetti della tradizione critica, le
considerazioni consuete sulla funzione morale dell'arte e
sul suo scopo di distogliere gli uomini dal vizio e di indurli
ad azioni virtuose ed onorevoli[ix]
o, come in Elementi di
legge, rilievi sull'influenza che la tragedia
può esercitare[x]
ma, ci sembra, dopo avere riconosciuto il peso che concezioni
così diffuse e consolidate potevano avere al suo tempo, che
Hobbes, nella sua riflessione filosofica intorno all'ingegno,
al linguaggio e alla bellezza, introduca alcuni elementi che
prefigurano un diverso percorso giungendo a giustificare
teoricamente un'attività intelletturale governata da una
facoltà, l'immaginazione, che opera connessioni inedite con
un gioco che ha il suo fine nel piacere che esso semplicemente
e immediatamente produce. Vediamo
innanzitutto la netta distinzione che Hobbes autorevolmente
delinea e sancisce[xi]
nelle sue pagine fra le due facoltà della mente umana,
fantasia o immaginazione e giudizio e fra le loro rispettive
funzioni. L'immaginazione è in Hobbes una facoltà molto
importante e complessa e Hobbes ne delinea con precisione la
ricca fenomenologia. È noto che per Hobbes la causa dei
nostri concetti o immagini è l'azione degli oggetti esterni
sui nostri organi di senso; infatti "non si dà nessuna
concezione nella mente umana che non sia generata
inizialmente, in tutto o in parte, dagli organi di senso".[xii]
Queste immagini o fancies,
che non sono nulla di reale nell'oggetto ma solo ciò che
appare a noi di quel movimento che l'oggetto opera,
attraverso i nervi, nel cervello[xiii]
o nel cuore,[xiv] non scompaiono quando l'oggetto si
sottrae ai nostri sensi ma restano, per quanto più deboli e
meno chiare, oppure noi possiamo richiamarle, e questa
sensazione illanguidita (decaying)
che permane dopo l'atto del senso è l'immaginazione o
fantasia che, quando si voglia esprimere soprattutto l'indebolimento,
l'attenuazione, l'essere passata, si chiama anche memoria.[xv]
Ma l'immaginazione non è soltanto riproduzione passiva e
debole dell'immagine della percezione sensibile; essa può
anche liberamente unire, comporre immagini apparse
isolatamente al senso come ad esempio un cavallo alato, una
montagna d'oro, o un centauro, e dunque può costruire
immagini mai prima percepite come tali in natura, può
inventare figure nuove che Hobbes chiama significativamente
finzioni della mente (Fictions
of the mind).[xvi] In
tale immaginazione composta (compounded
imagination), e nel suo distacco dalla semplice
funzione riproduttiva e gnoseologica della simple
imagination o memory,
è la premessa di quell'operare della fantasia artistica cui
Hobbes fa riferimento nel passo già citato di Elementi
di legge ma che descrive più pienamente,
riconoscendone la dignità e l'importanza, nell'esordio
del De principiis.[xvii]
In questo passo famoso, poi ripreso nella Answer
to sir Davenant's preface before Gondibert,
Hobbes mette espressamente la fantasia in relazione con le
opere d'arte e ne caratterizza
l'attività come una rapida combinazione di immagini
lontanissime, come una veloce connessione di dati sensibili
entro il copioso deposito di materiali che la memoria le
fornisce e che viceversa il giudizio provvede a ordinare e
distinguere. Al giudizio che lavora esaminando con gravità e rigore tutte le parti della
natura e registrando con lettere il loro ordine, cause, usi e
differenze ecc., cui spetta dunque il compito severo della scienza, viene
opposta la fantasia che, quando deve essere eseguita qualunque opera d'arte, trova i
suoi materiali pronti sottomano per usarli e non ha bisogno d'altro
che di muoversi rapidamente dall'uno all'altro [...].
Così che quando sembra volare da un'India all'altra, e
dal cielo alla terra e penetrare nelle cose più difficili e
nei luoghi più oscuri, nel futuro [...] il viaggio non è
lungo perché essa non fa che andare verso se stessa e la sua
meravigliosa rapidità non consiste tanto in movimento, quanto
in una abbondante provvista di immagini bene ordinate e
registrate perfettamente nella memoria.[xviii] Attingendo entro il bagaglio della
memoria, l'immaginazione o fantasia gioca veloce con le
immagini, le unisce in maniera nuova cogliendo nessi
impreveduti o, come Hobbes scrive con espressione felice nel De
Homine, "confonde gioiosamente oggetti dissimili".[xix]
Essa gioca anche con le parole. Il collegamento fra fantasia e
linguaggio metaforico ricorre infatti costantemente nelle
formulazioni hobbesiane dell'ingegno, non solo in quella di Elementi
di legge cui si è fatto precedentemente
riferimento ma anche nelle pagine molto dense del Leviatano
in cui, riprendendo l'analisi di quella virtù
intellettuale, Hobbes ribadisce la distinzione dell'immaginazione
e del giudizio e delle loro rispettive funzioni. Qui,
tuttavia, dove sembra prevalere una preoccupazione di tipo
metodologico e scientifico, egli accentua particolarmente l'importanza
del giudizio entro l'operare dell'ingegno; se infatti l'immaginazione
consiste nella felicità di cogliere somiglianze raramente
osservate da altri mentre una buona capacità di giudizio
risiede nel distinguere, discernere, giudicare una cosa
rispetto ad un'altra, nel caso che queste distinzioni non
siano facili, solo una collaborazione molto stretta di
immaginazione e giudizio possono caratterizzare secondo Hobbes
il vero ingegno. Anzi egli giunge ad affermare che il giudizio senza immaginazione è ingegno ma non lo è l'immaginazione
senza giudizio.[xx] L'intervento del giudizio, la discretion,[xxi]
deve frenare e ordinare mantenendo la direzione dei pensieri
al fine che una immaginazione troppo vivace potrebbe smarrire
e deve dunque esercitare un fermo controllo sulla fantasia
che, abbandonata a se stessa, cadrebbe nella stravaganza di
collegamenti incomprensibili o inopportuni. Laddove il
giudizio le ritagli le ali, una ricca fantasia saprà trovare
legittimamente e con facilità le similitudini e le metafore
appropriate che piaceranno "per la rarità delle loro
invenzioni".[xxii] Consideriamo pertanto più da vicino la
connessione che Hobbes pone fra giudizio, immaginazione e
linguaggio. Il
giudizio esamina con gravità e rigore tutte le parti della
natura e le registra con nomi; la sua capacità di discernere,
trovando dissomiglianze laddove appaiono somiglianze, sembra
dunque essere il fondamento dell'univocità e della costanza
dei nessi tra quei segni sensibili, arbitrariamente imposti,
che sono i nomi, e i concetti, che è il presupposto stesso
del discorso scientifico. Per Hobbes infatti la scienza è un
metodo, una disciplina del linguaggio secondo il modello
matematico del calcolo. Ragionare non è altro che calcolare
le conseguenze dei nomi univocamente definiti. La ragione,
come Hobbes scrive nel Leviatano, si consegue con l'industria, cominciando dalla corretta
attribuzione dei nomi e impadronendosi successivamente di un
metodo buono e ordinato nel procedere dagli elementi che sono
i nomi, alle asserzioni che risultano dalla loro connessione,
e ai sillogismi che sono connessioni di asserzioni, fino a
raggiungere la conoscenza di tutte le conseguenze dei nomi che
appartengono all'argomento in questione.[xxiii] In
tal modo, nominando i nostri concetti in modo rigoroso,
operazione cui presiede il giudizio, e acquisendo un metodo
corretto di calcolo, si costruiscono edifici
logico-linguistici coerenti (cui inerisce il valore di verità
o falsità), che hanno alla loro base punti di contatto
incontrovertibili con i dati sensibili significati (la scienza
è "evidenza di verità")[xxiv]
in grado di estendere l'ambito di previsione al di là di
ogni esperienza particolare. Questa
connessione fra giudizio e specificità del linguaggio spiega
la ragione per cui Hobbes, analizzando nel Leviatano
il tipo di ingegno che presiede alle varie attività
intellettuali umane, afferma che "in ogni ricerca rigorosa
della verità la capacità di giudizio è tutto", ed esclude
dall'ambito della scienza le metafore "che professano
apertamente l'inganno".[xxv]
Alcune pagine prima, definendo la ragione e la scienza, tale
esclusione suonava ancor più netta e definitiva: La luce della mente umana sono i termini chiari, selezionati
preliminarmente attraverso definizioni chiare e purgate dall'ambiguità
[...]. Al contrario le metafore e le parole ambigue e senza
senso sono come ignes fatui;
ragionare su queste equivale a perdersi fra innumerevoli
assurdità e il loro risultato sono la contesa, la sedizione e
il disprezzo.[xxvi] Quando
appunto si tratta di ragionare, cioè di calcolare, le parole
devono mantenere significati costanti e su questo piano
giocare con le parole è opera di mistificazione che fa
nascere opinioni infondate. Viceversa
la fantasia sembra avere una stretta relazione con l'equivocità
del linguaggio. Cogliendo improvvisamente fra le cose
somiglianze imprevedute, essa turba e perverte l'ordine
istituito del linguaggio e favorisce il gioco della metafora
in cui una parola viene spostata dal significato stabilito per
indicare qualcosa d'altro sulla base di una somiglianza
intravista. Gli appellativi che sono universali e comuni a più cose -
scrive Hobbes in Elementi
di legge - non sono sempre dati a tutti i
particolari secondo concetti e considerazioni simili in tutti;
e questa è la ragione per cui molti di essi non hanno un
significato costante, ma recano nella nostra mente pensieri
diversi da quelli per i quali erano stati istituiti; e questi
sono chiamati equivoci [...]. Anche tutte le metafore sono
(per definizione) equivoche.[xxvii] Se
dunque il giudizio con la sua funzione di discriminare e di
distinguere è la facoltà naturale che, aggiunta all'acquisizione
di un metodo rigoroso di calcolo, permette la costruzione
della scienza fondata sull'uso univoco dei nomi, la fantasia
con il suo gioco rapido che scompagina il riferimento delle
parole ai significati stabiliti presiede all'attività
artistica e alla retorica. Si
tratta ora di riprendere l'esame dell'operare ingegnoso
nella poesia e nella retorica, così come Hobbes lo configura,
per vedere se l'uso del linguaggio figurato, che pertiene ad
entrambe, e che del resto Hobbes ritiene proprio anche del
parlare comune,[xxviii]
non si riveli funzionale, nell'uno e nell'altro caso, ad
esiti diversi. Trattando nel Leviatano,
dei tipi di ingegno richiesti per le varie attività
intellettuali dell'uomo, Hobbes si sofferma anche sulla
poesia e sull'eloquenza e sembrano emergere alcune rilevanti
differenze. In una buona poesia - egli scrive - sia essa epica o
drammatica come anche nei sonetti, negli epigrammi e in altre
composizioni, sono necessarie sia la capacità di giudizio che
l'immaginazione. L'immaginazione deve però prevalere
perché queste composizioni piacciono per la loro
eccentricità ma non devono dispiacere per la mancanza di
discrezione.[xxix] Dunque
immaginazione e giudizio devono operare insieme affinché la
ricchezza e la novità degli accostamenti imprevisti dell'immaginazione,
mancando di una guida e di un controllo che orienti fermamente
verso un fine, non degeneri in una specie di "follia" e
questa attività di discretion
del giudizio, che frena e contiene la fantasia, si configura
come organizzazione del molteplice in una unità. Infatti
nella prefazione, To the
Reader, alla traduzione dei poemi omerici che
tratta delle virtues of an
heroic poem, Hobbes chiarisce inequivocabilmente
che la discrezione sta in ciò che tutte le parti del poema sian
tali da condurre ad essere ordinate per rapporto al proposito
e disegno del poeta.[xxx] Ma
tale collaborazione si inscrive nel segno della preminenza
della varietà, e dunque della fantasia e della ricchezza del
gioco metaforico del linguaggio che deve procurare piacere per
la novità e la rarità delle sue invenzioni; in questo caso
il fine della fantasia e dell'uso linguistico figurato è
semplicemente quello di dar piacere, il piacere naturale e
proprio dell'uomo di cogliere relazioni nuove ed inaspettate
fra le cose.[xxxi]
Viceversa, nelle varie forme di eloquenza, il gioco dell'immaginazione
ed il linguaggio figurato che gli appartiene non vengono messi
in relazione semplicemente con il piacere ma con il fine di
sopraffare emotivamente mistificando la realtà. "Nei
panegirici e nelle invettive l'immaginazione è predominante
perché non si mira alla realtà ma all'onore e al
disonore..." e "nelle esortazioni e nelle difese secondo
che serva meglio allo scopo prefisso la verità o la
dissimulazione, sarà principalmente necessaria la capacità
di giudizio o l'immaginazione...".[xxxii]
Laddove, come nella scienza, è in questione la verità, il
giudizio (e il linguaggio rigoroso che gli pertiene) domina
incontrastato ma se il fine è la dissimulazione, se si tratta
di produrre un'apparenza di verità che convinca e seduca
gli ascoltatori è l'immaginazione che agisce con il suo
potere di fare assumere alle parole significati diversi in
relazione alle passioni diverse di coloro che le usano. L'eloquenza - scrive Hobbes in Elementi di legge - non è altro che il potere di ottenere
credito in ciò che diciamo, e a questo fine dobbiamo trarre
aiuto dalle passioni dell'ascoltatore [...]. E tale è il
potere dell'eloquenza, che molte volte grazie ad essa un
uomo viene indotto a credere di sentire sensibilmente dolore e
danno, quando non sente nulla, e ad entrare in uno stato di
indignazione, senz'altra causa di quella che risiede nelle
parole e nella passione dell'oratore.[xxxiii] La
persuasione infatti mira a far nascere un'opinione da una
passione,[xxxiv]
per cui la facoltà di parlare con potenza consiste in una abitudine
acquisita di mettere insieme parole appassionate, e di
applicarle alle presenti passioni dell'ascoltatore.[xxxv] Mentre
nella retorica l'attività dell'immaginazione e le
espressioni ingegnose che ne conseguono sono funzionali a
muovere gli animi per ottenere il consenso intorno ad un'opinione
o ad un'azione, nell'arte l'immaginazione crea finzioni
ricorrendo al gioco metaforico delle parole ma in funzione di
produrre semplicemente meraviglia e piacere. In entrambi i
casi non è in questione la verità poiché "non la verità,
ma l'immagine crea la passione",[xxxvi]
ma nella retorica il fine è esterno all'opera: ottenere il
consenso, indurre un'opinione, convincere ad un'azione;
nella poesia l'elemento illusorio ha il suo fine solamente
nel piacere che produce. Infatti nell'esame che Hobbes
conduce nel Leviatano
degli usi particolari del discorso, egli ne indica uno che
può offrire "piacere e diletto [...] attraverso il gioco innocente
delle parole fatto per piacere o per ornamento" ben distinto
da quell'abuso che mira, mediante l'uso metaforico delle
parole, ad "ingannare gli altri".[xxxvii]
È vero che parlando di "ornamento" o, come nel De
corpore dove viene ripresa la distinzione, di "abbellimento",[xxxviii]
Hobbes ha presente una concezione esornativa del linguaggio
che è propriamente di matrice retorica e che appanna un poco
il valore delle sue affermazioni, ma resta il fatto che,
attraverso la distinzione netta fra piacere e ornamento ovvero
inganno, viene riconosciuta un'attività dell'immaginazione
che non ha altro fine se non il piacere che produce e che solo
in esso trae la sua piena giustificazione, senza alcuna
diretta implicazione pratica. Tale intuizione di un gioco
innocente dell'immaginazione che ha in sé la sua finalità
trova conferma anche nella trattazione hobbesiana della
bellezza. E che essa implichi delle difficoltà si rivela già
dal fatto che Hobbes denuncia in proposito un problema
terminologico e ricorre alla parola latina pulchritudo dichiarando che manca nella lingua inglese un
termine perfettamente corrispondente.[xxxix]
Come ha opportunamente sottolineato in proposito il
Tatarkiewicz, "si tratta di un'osservazione interessante
per quel che riguarda la terminologia dell'estetica" dalla
quale egli deduce che "inizialmente vi erano vari termini
estetici particolari, ciascuno con un limitato campo di
applicazione" (e Hobbes infatti cita, nel Leviatano,
fair, beautiful,
gallant, honourable,
amable), "sostituiti con il passare del tempo da uno solo
di essi, che gradualmente aveva ampliato il proprio
significato fino ad abbracciare tutto il campo dei fenomeni
estetici".[xl]
Ma proprio in questa prospettiva giova poi rilevare che entro
l'ambito dell'accezione molto ampia, di stampo latino,
della pulchritudo,
che Hobbes fa proprio, egli sembra individuare anche una
dimensione puramente formale della bellezza. Secondo la
formulazione del Leviatano, pulchrum
è "ciò che per alcuni segni apparenti, promette del bene",[xli]
laddove bene è per ognuno, secondo Hobbes, quel che gli piace
e male quel che gli dispiace.[xlii] Ma poi ne distingue diverse specie che,
nella versione latina del Leviatano[xliii],
caratterizza con i termini formosus,
honestus, decorus,
jucundus,
indicando così entro un'accezione generalissima del termine
pulchritudo che
si estende anche alle azioni ed ai caratteri, una bellezza che
quanto meno è legata alla forma dal momento che viene
definita dall'aggettivo formosus
distinto per es. da honestus
o jucundus.
Ancor più esplicitamente, nel De
Homine, dove pure Hobbes definisce la bellezza in
generale come "quella qualità degli oggetti che fa sì che
ci se ne aspetti un bene", egli distingue entro il genere
più ampio della bellezza come indizio di un bene futuro, una
bellezza delle azioni, che si chiama "onestà", e una
bellezza della forma ed aggiunge che la bellezza "piace
anche prima che venga acquisito il bene di cui è indizio
grazie all'immaginazione".[xliv] Operando
questa distinzione, Hobbes, ci sembra, muove verso l'identificazione
di una dimensione estetica e formale della bellezza. Se
infatti affinché si provi un "piacere della mente"[xlv]
occorre sempre un intervento attivo dell'immaginazione che
mette in relazione le immagini del bene che ci si attende con
la sensibilità attuale, realizzando il piacere qui ed ora,
dobbiamo implicare una differenza nel caso che si tratti di
una bella azione ovvero di una forma bella. Infatti mentre, in
relazione ad una "bella" azione, l'immaginazione rende
attuale il piacere rappresentandomi le cose buone che ne
deriveranno, quando si tratta di una pura forma quel che conta
è il modo della rappresentazione ed è rispetto ad esso che l'immaginazione
realizza un piacere che non si risolve in niente altro. In tal
caso non è l'ottenimento di un bene futuro che viene
attualizzato dall'immaginazione ma la realizzazione del
bene, cioè il piacere, è opera dell'immaginazione in un
movimento che ha nella forma, nel modo della rappresentazione,
il suo inizio e la sua fine. Nel caso della forma bella, si
potrebbe dire, è l'immaginazione che motiva e realizza il
piacere, che conduce e conclude il gioco. Non ci si attende
altro se non quel piacere che l'immaginazione produce in
relazione alla forma. L'introduzione di una bellezza che
consiste nella forma e di un piacere dell'immaginazione ad
esso relativo rappresenta pertanto l'importante
riconoscimento di un processo tutto interno all'immaginazione,
che non ha in vista null'altro al di fuori di sé. Nell'ambito
complessivo di una nozione di bellezza che si estende a tutti
gli aspetti o segni delle cose che contengono la promessa di
un bene, si specifica un'accezione particolare, più
ristretta, che consiste nella pura forma; e in questo caso,
conviene sottolinearlo, l'immaginazione viene per così dire
motivata e coinvolta nel modo della rappresentazione e da
questo solo si trae il piacere. È
forse opportuno non forzare oltre le scarne considerazioni
hobbesiane sulla bellezza, per quanto appaiano rilevanti. Si
tratta evidentemente di spunti che emergono intorno ad un
problema quale l'arte, e la poesia in particolare, che nelle
opere filosofiche di Hobbes occupa un posto abbastanza
marginale nell'economia dell'intero sistema. E tuttavia ci
sembra non privo di interesse sottolinare, nell'antropologia
hobbesiana, l'emergere della fisionomia di un ambito
estetico autonomo rispetto a quello scientifico ed anche a
quello propriamente retorico; un ambito dominato da una
facoltà, la fantasia o immaginazione, che deve collaborare
con il giudizio (la cui funzione su questo piano è di
contenimento e di controllo), in cui l'uso del linguaggio
figurato che si avvale di similitudini e di metafore,
linguaggio che appartiene anche ad altri ambiti (linguaggio
comune, eloquenza), si risignifica nei confronti di una
finalità che gli è propria, il semplice piacere.
Immaginazione, metafora, piacere: ecco gli elementi
funzionalmente interdipendenti che configurano l'ambito
specifico dell'arte, distinto nettamente da quello della
scienza e, con una linea più sottile, ambigua, sfumata, anche
da quello della retorica. Il gioco della poesia è
innocente... Esso non mira a persuadere o a veicolare con
tutti gli ornamenti appropriati verità o convinzioni morali
ma l'illusione delle sue finzioni ci attrae con un piacere
che è fine a se stesso. E se in Hobbes il piacere "è anche
una sollecitazione o provocazione ad avvicinarsi alla cosa che
piace",[xlvi]
nel caso dell'arte ciò si potrebbe tradurre nella tendenza
a protrarre il gioco dell'immaginazione, che rinnova il
piacere stesso. Per comprendere come sia possibile
che Hobbes, così impegnato nella costruzione di un sistema
rigorosamente materialistico e meccanicistico, venga
riconoscendo in qualche modo un'attività della mente che ha
il suo fine in se stessa e ne profili le modalità, forse non
è ininfluente ricordareil fatto che dietro la riflessione
hobbesiana su questi temi vi è "a rather wide and intimate
experience of imaginative literature",[xlvii]
che egli fu in proprio anche uomo di lettere e di gusto
riconosciuto e che, a lato dell'impegno filosofico, coltivò
una costante e partecipe attenzione ai fatti della
letteratura. E proprio la marginalità stessa del problema
rispetto alle sue preoccupazioni speculative dominanti possono
averlo reso fruttuosamente meno sorvegliato, lasciando
trasparire, pur nella mancanza di un contesto teorico
organico, una prospettiva che in Locke doveva trovare una ben
più matura, piena, e stimolante affermazione.[xlviii] [i]
Quest'opera fu pubblicata, per la prima volta, a Londra
nel 1650 sotto forma di due opere separate, intitolate
rispettivamente Human
nature e De
corpore politico; ma era stata redatta nel 1640
e circolò manoscritta. Nel 1889 Ferdinand Tönnies
pubblicò la trascrizione del manoscritto originale
reintegrando anche il titolo primitivo Elements
of Law Natural and Politic. Si cita dalla
traduzione italiana: Elementi
di legge naturale e politica, a cura di A.
Pacchi, Firenze, 1968 (d'ora in poi indicata con la
sigla EL). [ii]
EL, pp. 3-4.
La distinzione fra i due tipi di dotti (matematici e
dogmatici) viene ripresa anche in EL,
XIII, 3, p. 104. [iii]
Per gli attacchi di cui Hobbes fu oggetto da parte dei
contemporanei inglesi si veda S. I. Mintz, The Hunting of
Leviathan, Cambridge, 1962. Un quadro delle
critiche più o meno feroci che Hobbes dovette
fronteggiare è delineato da A. Pacchi nella Introduzione
a Th. Hobbes, Leviatano,
Bari, 1989, pp. XXI-XXIX (d'ora in poi indicato con la
sigla L). [iv]
Se ne veda l'orgogliosa rivendicazione nella Lettera
dedicatoria a Il
corpo in Elementi
di filosofia. Il corpo - L'uomo, a cura di A.
Pacchi, Torino, 1972, p. 63 (d'ora in poi EF). [v]
Th. Hobbes, Il corpo,
I, 7, in EF,
pp. 75-6. [vi]
Per l'identificazione di fantasia e immaginazione si
veda EL, p.
21 e L,
p. 15. Già nel
pensiero classico vi era quella confusione fra fantasia e
immaginazione che, protrattasi anche lungo il pensiero
medievale, Hobbes eredita pienamente; in Hobbes infatti i
due termini vengono usati per lo più come sinonimi. Per
una ricostruzione del problema da Platone ai neoplatonici
e nel pensiero medievale si veda Phantasiaimaginatio,
Atti del V Colloquio internazionale del Lessico
intellettuale europeo, Roma, 1986, pp. 23-184. Utile
anche, in quanto esamina i predecessori di Hobbes sul
tema, C. De Witt
Thorpe, The
aesthetic Theory of Th. Hobbes,
London-Oxford, 1940, pp. 37-48. Più
in generale si veda sul tema dell'immaginazione nella
riflessione filosofica l'analisi di M. Ferraris
in L'immaginazione,
Bologna, 1996. [vii]
EL,
pp. 78-80. [viii]
Accanto alla preminente attività filosofica e
scientifica, Hobbes coltivò per tutta la vita un vivo
interesse per la letteratura. Amico di letterati e poeti,
tradusse in inglese Tucidide e, in età assai avanzata, i
poemi omerici, premettendovi un'importante prefazione
sui pregi del poema eroico. Che anche in campo letterario
le sue opinioni fossero tenute in gran conto è dimostrato
dal fatto che il Davenant gli dedicò il suo poema Gondibert,
sottoponendogliene la visione prima che fosse pubblicato e
che Hobbes si premurò di rispondergli trattando del Gondibert
e del poema eroico in generale. Inoltre, per il giovane
duca di Cavendish di cui era precettore, Hobbes compilò,
fra il 1631 e il 1638, una traduzione-compendio della Retorica
di Aristotele, più volte ristampata nel corso del secolo
(si veda in proposito W.
S. Howell, Logic
and Rhetoric in England, New York, 1961, p.
384). Per una delineazione dell'attività letteraria e
critica di Hobbes e del suo rilievo, si veda C.
De Witt Thorpe, op. cit.,
pp. 3-5; 150-169. [ix]
Si veda per es. The Answer to sir Davenant's Preface before Gondibert,
in Th. Hobbes,
English Works,
a cura di Sir William Molesworth, London, 1839-45, vol. IV,
p. 443. [x]
EL,
p. 105. [xi]
La distinzione era già presente in Bacone il quale nel De
Augmentiis (II,1) divide tutto il sapere umano
in storia, poesia e filosofia secondo le tre facoltà
della mente: memoria, fantasia e ragione. Come scrive L.
Anceschi, "la distinzione fra scienza e fantasia"
posta da Bacone "costituisce il fondamento di tutta l'estetica
dell'empirismo inglese". L.
Anceschi, Tre
studi di estetica, Milano, 1966, pp. 41-2. Sull'estetica
di Bacone si veda anche, dello stesso autore, Da
Bacone a Kant, Bologna, 1972, pp. 37-67. [xii]
L,
p. 11. [xiii]
EL,
p. 14. [xiv]
L, p. 11. [xv]
EL,
p. 21; L,
pp. 14-5. [xvi]
EL,
p. 23; L,
p. 16. [xvii]
De principiis
cognitionis et actionis è il titolo, tratto
dalle parole iniziali, con cui M. M. Rossi ha trascritto e
pubblicato un manoscritto hobbesiano scoperto fra le carte
di Herbert di Cherbury, datandolo fra il 1637 e il 1640.
Si veda M. M. Rossi,
L'evoluzione del
pensiero di Hobbes alla luce di un nuovo manoscritto
in "Civiltà moderna", 1941, XIII, pp. 125-50; 217-46;
366-402. Il Rossi ha ripubblicato il testo del manoscritto
e lo studio che lo commenta in Alle
fonti del deismo e del materialismo moderno,
Firenze, 1942, pp. 103-94. L'esordio del De
principiis fu inserito da Hobbes nella sua
risposta a sir Davenant relativa al Gondibert. [xviii]
The Answer,
ed. cit.,
vol. IV, p.
449. G. Morpurgo-Tagliabue, citando questo passo,
sottolinea il carattere antiromantico dell'immaginazione
hobbesiana, che, nel suo ricondursi ad operare sulla
memoria, non ha nulla di "alato, sfrenato, pegaseo" (G.
Morpurgo-Tagliabue, Anatomia
del barocco, Palermo, 1987, pp. 49-50). [xix]
Th. Hobbes, De
Homine, a cura di A. Pacchi, Bari, 1970, p.
166. [xx]
L, p. 59. [xxi]
Sulla "discrezione" si veda L,
pp. 57-9; sulla sua funzione in ambito poetico si veda To
the Reader
(1675) dove Hobbes scrive: "... nella fantasia
sta la sublimità di un poeta, quell'empito poetico che
quasi tutti i lettori cercano. Essa vola via rapidamente
per riportare argomenti e parole, ma se non trova a casa
sua discrezione sufficiente a distinguere quali sono
adatte ad essere usate e quali no, quali sono decenti e
quali inopportune date le persone, il momento e il luogo,
vanno perduti il diletto che possono dare e la loro grazia"
(To the Reader,
in English Works,
vol. X, p. V). [xxii]
L, p. 57. [xxiii]
L, p. 38. [xxiv]
EL,
p. 45. [xxv]
L, p. 58. [xxvi]
L, pp.
39-40. [xxvii]
EL,
p. 37. Per un'ampia esposizione del problema
del linguaggio in Hobbes si veda: L.
Formigari, Linguistica
ed empirismo nel Seicento inglese, Bari, 1970,
pp. 141-155. Molto utile per il rilievo del nesso fra
immaginazione e linguaggio: C. A. Viano, Analisi della
vita emotiva e tecnica politica nella filosofia di Hobbes,
in "Rivista critica di storia della
filosofia", XVII, 4, 1962, pp. 355-92. [xxviii]
L, p. 38. [xxix]
L, p. 58. [xxx]
Cfr. To the Reader,
ed. cit., vol. X, p. III. [xxxi]
L, p. 46. [xxxii]
L, p. 59; [xxxiii]
EL,
pp. 247-8. [xxxiv]
EL,
p. 105; [xxxv]
EL,
p. 248. L'atteggiamento di Hobbes nei
confronti della retorica, fomentatrice di rivolte e di
sedizioni, e pertanto pericolosa per l'ordine
comunitario, è sempre molto polemico e negativo. Si veda
anche in Elementi
filosofici sul cittadino: "l'oratore [...]
non parte mai da principi veri, ma da opinioni già
accettate dalla massa, che per lo più sono erronee, e
cerca di mantenere il proprio discorso aderente non già
alla realtà delle cose ma alle passioni che hanno
investito gli animi [...] Del resto non si tratta
di un difetto proprio dell'uomo, ma insito nell'eloquenza
che, come insegnano tutti i maestri di retorica, non ha
per scopo l'esposizione della verità [...] ma la
vittoria, e suo compito non è di ammaestrare, ma di
persuadere." (Th.
Hobbes, Elementi
filosofici sul cittadino, in Opere
filosofiche, a cura di Norberto Bobbio, Torino,
1959, p. 221). Su questo aspetto e sul rapporto fra la
retorica e l'analisi delle passioni ha osservazioni
molto puntuali C.
A. Viano, op.
cit., pp. 355-61; 366-83. [xxxvi]
EL,
p. 105. [xxxvii]
L, p. 27
(cors. mio). [xxxviii]
Cfr. Il corpo, II, 12, in EF,
p. 87. [xxxix]
EL,
p. 51. [xl]
W. Tatarkiewicz,
Storia dell'estetica,
III, Torino, 1980, pp. 474-5. [xli]
L, p. 43. [xlii]
EL,
p. 50. [xliii]
Th. Hobbes, Leviathan,
in Opera philosophica,
quae latine scripsit omnia, a cura di
Molesworth, London, 1939-45, vol. III, p. 42. [xliv]
De Homine,
cit., p. 150. [xlv]
La distinzione fra piaceri del senso e piaceri della
mente, i quali ultimi "sorgono dall'aspettazione che
procede dalla previsione del fine o dalla conseguenza
delle cose, se esse piacciono o dispiacciono al senso"
è posta in L,
p. 44; si veda anche EL,
pp. 55-61. Sulla correlazione fra piaceri della
mente ed immaginazione ci permettiamo di rimandare al
nostro Fancy, Judgment,
Wit in Th. Hobbes, "Studi di estetica",
1977, 4, pp. 33-41. [xlvi]
EL, p.
50. [xlvii]
Cfr. C. De Witt
Thorpe, op. cit.,
p. 6. [xlviii]
Se ne veda l'analisi penetrante e sicura di L.
Cozzoli, in L'equivoco
della metafora, Firenze, 1996, pp. 21-39.
|
|
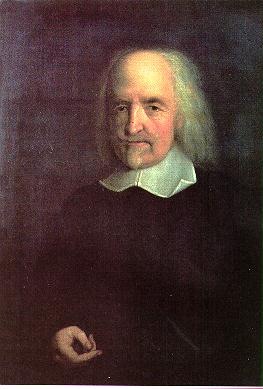 Fin
dall'
Fin
dall'